Il solito dilemma dello studente di Istologia è questo: come capisco cosa sto guardando?
In questo intervento poche semplici regole per non sbagliare (quasi) mai.
1) Cellularità
La prima domanda da porsi quando si osserva un preparato: quante cellule ci sono rispetto alla matrice extracellulare? Dal momento che quasi tutte le cellule dell’organismo presentano uno o più nuclei, identificare i nuclei è il fulcro di questo passaggio (ma occhio ad alcune notevoli eccezioni: eritrociti e piastrine, che sono più propriamente dei derivati di cellule, e corneociti, che sono più propriamente cellule degenerate). Ricordate che quando si colora un tessuto, si utilizza almeno un colorante basico, con affinità tintoriale per gli acidi nucleici del nucleo (esempi validi: ematossilina o azocarminio), proprio con lo scopo di identificare i nuclei -e quindi le cellule- presenti nel preparato, indipendentemente dall’affinità tintoriale del loro citoplasma. Facciamo subito degli esempi:
A sinistra cosa notiamo? Tanti nuclei, cioè tante cellule, molto ravvicinate, con scarsa matrice extracellulare. Sebbene non sia esclusiva caratteristica degli epiteli, l’abbondanza di cellule giustapposte è sicuramente l’elemento chiave per riconoscere il tessuto epiteliale. In questo caso si tratta di una ghiandola (esocrina, acinosa composta a secrezione sierosa), ma lo stesso vale chiaramente per gli epiteli di rivestimento (dove però riconosceremo sempre una superficie libera).
A destra? Pochi, pochissimi nuclei, ben distanziati tra loro, con un’abbondante matrice fibrosa irregolare (ben colorata) e amorfa (non evidente). Pochi dubbi, stiamo guardando un tessuto connettivo (moderatamente compatto, a fibre irregolari).
2) Architettura cellulare
Punto cruciale per identificare un tessuto è la valutazione della disposizione delle cellule che lo compongono, tra di loro e nei confronti della matrice. Se infatti la cellularità ci consente un’utilissima discriminazione tra ciò che è presumibilmente epiteliale/muscolare e ciò che è (ancor più) presumibilmente connettivale/nervoso, è la maniera in cui sono disposte le cellule a darci un’indicazione più precisa. Qualche esempio renderà meglio l’idea:
 E’ facile notare in questo preparato l’abbondanza di cellule giustapposte (è un epitelio, quindi). Ma le cellule come si dispongono? E’ apprezzabile una struttura “a fila indiana” di queste cellule, quasi a formare un cordone. Difatti questo è un preparato di ghiandola endocrina cordonale (dettaglio di zona fascicolata del corticosurrene);
E’ facile notare in questo preparato l’abbondanza di cellule giustapposte (è un epitelio, quindi). Ma le cellule come si dispongono? E’ apprezzabile una struttura “a fila indiana” di queste cellule, quasi a formare un cordone. Difatti questo è un preparato di ghiandola endocrina cordonale (dettaglio di zona fascicolata del corticosurrene);
 Qui la situazione è ancora più interessante… c’è un “mare” di tessuto grossomodo omogeneo, composto da cellule riunite in strutture acinari (acini ghiandolari). E cosa troviamo in mezzo al mare? Chiaramente un’isola! La struttura particolare che troviamo al centro dell’immagine è un’isola di Langerhans (quindi siamo nel pancreas). In questa, le cellule non formano più acini, ma le vediamo unite in piccoli cordoncini irregolari (quindi non lineari come nella precedente). Per l’appunto, le isole di Langerhans sono isolotti di tessuto endocrino cordonale.
Qui la situazione è ancora più interessante… c’è un “mare” di tessuto grossomodo omogeneo, composto da cellule riunite in strutture acinari (acini ghiandolari). E cosa troviamo in mezzo al mare? Chiaramente un’isola! La struttura particolare che troviamo al centro dell’immagine è un’isola di Langerhans (quindi siamo nel pancreas). In questa, le cellule non formano più acini, ma le vediamo unite in piccoli cordoncini irregolari (quindi non lineari come nella precedente). Per l’appunto, le isole di Langerhans sono isolotti di tessuto endocrino cordonale.
 Come sono disposte le cellule in questa immagine? In primo luogo distinguiamo 2 aree irregolari: una “piena” (quella che si colora fortemente) ed una “vuota” (scarsamente colorata). Come descrivereste quelle aree “piene”? Gli istologi usano il termine “trabecola” (cioè “piccola trave”, in Latino). All’interno delle trabecole, intrappolate in minuscole lacune, troviamo delle piccole cellule, che i più attenti avranno già riconosciuto come osteociti. Ma non è tutto! Se poniamo attenzione alla periferia delle trabecole (soprattutto di quella sottile al centro), notiamo delle cellule disposte in fila (cellule a palizzata o “lining cells”), che possiamo identificare come osteoblasti. L’enorme presenza di osteoblasti attivi e la assenza di midollo osseo negli spazi tra le trabecole (che si ritrova fisiologicamente nello scheletro adulto), uniti ad uno “sprazzo” di tessuto mesenchimale (visibile in alto a destra) ci inducono a pensare che questa sia un’immagine di ossificazione intramembranosa o diretta.
Come sono disposte le cellule in questa immagine? In primo luogo distinguiamo 2 aree irregolari: una “piena” (quella che si colora fortemente) ed una “vuota” (scarsamente colorata). Come descrivereste quelle aree “piene”? Gli istologi usano il termine “trabecola” (cioè “piccola trave”, in Latino). All’interno delle trabecole, intrappolate in minuscole lacune, troviamo delle piccole cellule, che i più attenti avranno già riconosciuto come osteociti. Ma non è tutto! Se poniamo attenzione alla periferia delle trabecole (soprattutto di quella sottile al centro), notiamo delle cellule disposte in fila (cellule a palizzata o “lining cells”), che possiamo identificare come osteoblasti. L’enorme presenza di osteoblasti attivi e la assenza di midollo osseo negli spazi tra le trabecole (che si ritrova fisiologicamente nello scheletro adulto), uniti ad uno “sprazzo” di tessuto mesenchimale (visibile in alto a destra) ci inducono a pensare che questa sia un’immagine di ossificazione intramembranosa o diretta.
 Questa è facile: anche qui vediamo tante cellule giustapposte (epitelio!), che si affacciano su una superficie libera (epitelio di rivestimento!). E’ evidente il limite tra il connettivo sottostante (pochi nuclei, fibre abbondanti e irregolari) e lo strato epiteliale, caratterizzato dalla formazione di “papille” (quelle strutture date dall’invaginazione della membrana basale, che in alcune sezioni come questa, può dare la falsa impressione che vi sia un’isolotto di connettivo nell’epitelio). Qual è l’architettura di questo epitelio di rivestimento? Ogni volta che ci troviamo a fronteggiare un epitelio di rivestimento dobbiamo considerare: il numero di strati (in questo caso tanti), la forma delle cellule negli strati più superficiali (in questo caso è vistosamente pavimentosa), la presenza o meno di strato cheratinizzato (che cerchiamo solo nel caso di epitelio pavimentoso stratificato, che è presente in questo caso). Il reperto di epitelio pavimentoso stratificato, dello strato corneo e della citomorfosi che si palesa nei diversi strati del tessuto ci porta a concludere che ci troviamo davanti a epidermide.
Questa è facile: anche qui vediamo tante cellule giustapposte (epitelio!), che si affacciano su una superficie libera (epitelio di rivestimento!). E’ evidente il limite tra il connettivo sottostante (pochi nuclei, fibre abbondanti e irregolari) e lo strato epiteliale, caratterizzato dalla formazione di “papille” (quelle strutture date dall’invaginazione della membrana basale, che in alcune sezioni come questa, può dare la falsa impressione che vi sia un’isolotto di connettivo nell’epitelio). Qual è l’architettura di questo epitelio di rivestimento? Ogni volta che ci troviamo a fronteggiare un epitelio di rivestimento dobbiamo considerare: il numero di strati (in questo caso tanti), la forma delle cellule negli strati più superficiali (in questo caso è vistosamente pavimentosa), la presenza o meno di strato cheratinizzato (che cerchiamo solo nel caso di epitelio pavimentoso stratificato, che è presente in questo caso). Il reperto di epitelio pavimentoso stratificato, dello strato corneo e della citomorfosi che si palesa nei diversi strati del tessuto ci porta a concludere che ci troviamo davanti a epidermide.
3) Morfologia cellulare
In realtà è impossibile considerare l’architettura delle cellule di un tessuto senza valutare la loro forma. Ci sono casi in cui, però, la morfologia delle singole cellule è fondamentale per identificare il tipo di tessuto. Ecco qualche esempio:
 Il tessuto adiposo univacuolare lo si riconosce per la tipica forma degli adipociti (una grossa gocciola non colorata, con un nucleo schiacciato contro la membrana cellulare, che risulta ben evidente).
Il tessuto adiposo univacuolare lo si riconosce per la tipica forma degli adipociti (una grossa gocciola non colorata, con un nucleo schiacciato contro la membrana cellulare, che risulta ben evidente).
I tessuti muscolari condividono la caratteristica di essere costituiti da cellule allungate, orientate in fascetti o fasci piò o meno regolari, con un citoplasma ben colorabile. Ci sono degli elementi morfologici da considerare per distinguerli, e qui verranno schematizzati. Tutte le immagini sono in sezione longitudinale.
 Striato scheletrico: ogni fibrocellula è di forma regolare e molto allungata (“esce” dal campo), ben visibile è la tipica striatura (trasversale alla direzione della fibra), i nuclei sono disposti alla periferia della cellula (si tratta di “sincizi”, quindi cellule multinucleate, originate dalla fusione in epoca embrionale di elementi mononucleati di derivazione mesenchimale, i mioblasti). Al microscopio ottico, agli ingrandimenti permessi, non si riconosce altro, ma questo basta per identificare il tessuto.
Striato scheletrico: ogni fibrocellula è di forma regolare e molto allungata (“esce” dal campo), ben visibile è la tipica striatura (trasversale alla direzione della fibra), i nuclei sono disposti alla periferia della cellula (si tratta di “sincizi”, quindi cellule multinucleate, originate dalla fusione in epoca embrionale di elementi mononucleati di derivazione mesenchimale, i mioblasti). Al microscopio ottico, agli ingrandimenti permessi, non si riconosce altro, ma questo basta per identificare il tessuto.
 Striato cardiaco: le strie ci sono anche qui (anche se non ben visibili). Differenze salienti? Vediamo che i nuclei, di forma un po’ schiacciata, sono posti al centro della fibrocellula e non alla periferia, e che soprattutto le cellule sono mononucleate (raramente binucleate). La forma non è più regolare come nello striato scheletrico (è visibile al centro una cellula con la tipica biforcazione del plasmalemma – che crea la forma “a Y” o “a pantalone”). Ancora, notiamo che le cellule sono strettamente collegate tra loro in senso longitudinale, e che lungo le superfici di contatto sono presenti le “strie scanaliformi” (o “dischi intercalari”), così importanti per la fisiologia cardiaca.
Striato cardiaco: le strie ci sono anche qui (anche se non ben visibili). Differenze salienti? Vediamo che i nuclei, di forma un po’ schiacciata, sono posti al centro della fibrocellula e non alla periferia, e che soprattutto le cellule sono mononucleate (raramente binucleate). La forma non è più regolare come nello striato scheletrico (è visibile al centro una cellula con la tipica biforcazione del plasmalemma – che crea la forma “a Y” o “a pantalone”). Ancora, notiamo che le cellule sono strettamente collegate tra loro in senso longitudinale, e che lungo le superfici di contatto sono presenti le “strie scanaliformi” (o “dischi intercalari”), così importanti per la fisiologia cardiaca.
 Muscolo liscio: anche qui fascetti di cellule, ma con qualche differenza. Le cellule sono fusate (come i fibroblasti), cioè presentano un restringimento alle estremità. I nuclei sono chiaramente allungati (“a sigaro”), posizionati al centro della cellula, e li ritroviamo sfalsati tra due cellule parallele. Nessuna striatura è evidenziabile.
Muscolo liscio: anche qui fascetti di cellule, ma con qualche differenza. Le cellule sono fusate (come i fibroblasti), cioè presentano un restringimento alle estremità. I nuclei sono chiaramente allungati (“a sigaro”), posizionati al centro della cellula, e li ritroviamo sfalsati tra due cellule parallele. Nessuna striatura è evidenziabile.
Queste due immagini dimostrano l’importanza assoluta della morfologia cellulare nel riconoscere il tessuto nervoso: a sinistra abbiamo un lampante esempio di neuroni multipolari (colorazione con metodo di Nissl) e a destra due cellule di Purkinje della corteccia cerebellare (metodo di Golgi). A sinistra inoltre notiamo chiaramente i nuclei delle cellule della neuroglia, che a destra non sono visibili.
Un ultimo esempio in cui la morfologia cellulare è fondamentale per l’analisi di un preparato è lo striscio di sangue. In ogni striscio, difatti, troviamo numerosissimi eritrociti e assai più rari leucociti, che vanno riconosciuti proprio in base alle loro caratteristiche citomorfologiche (forma del nucleo, rapporto nucleo/citoplasma, affinità tintoriale del citoplasma, presenza o meno di granulazioni citoplasmatiche). Su tutti i manuali e atlanti di Istologia, cui si rimanda, sono presenti numerosi e più efficaci esempi di quelli che possono essere inseriti in questo post.
4) Particolari affinità tintoriali /colorazioni specifiche
Di particolare ausilio in Istopatologia, ma molto meno importanti in Istologia normale, sono i metodi di colorazione specifici che evidenziano componenti cellulari o extracellulari di fondamentale importanza per la discriminazione tra un tessuto sano e uno patologico. Ci faremo bastare un solo esempio:
 In quest’immagine le cellule caliciformi mucipare (Goblet cells, nella dizione inglese) sono ben evidenziate in rosa acceso tramite la metodica PAS (Periodic Acid Schiff), che si contrappone all’ “otticamente vuoto” delle stesse cellule quando il tessuto viene colorato con ematossilina-eosina.
In quest’immagine le cellule caliciformi mucipare (Goblet cells, nella dizione inglese) sono ben evidenziate in rosa acceso tramite la metodica PAS (Periodic Acid Schiff), che si contrappone all’ “otticamente vuoto” delle stesse cellule quando il tessuto viene colorato con ematossilina-eosina.
Conclusioni
In questo post, che era tra le bozze da molto tempo, ho cercato di delineare un metodo semplice per orientarsi tra i diversi tessuti. Il metodo nasce dalla mia personale esperienza, e non ha pretese di essere il migliore o il definitivo. Il bravo studente sa che, alla fine dei fatti, ciò che aiuta di più nel riconoscimento dei tessuti e degli organi al microscopio è l’esercizio assiduo.
Ogni ulteriore suggerimento sarà accettato con gioia.
Pietro Paolo Vitiello
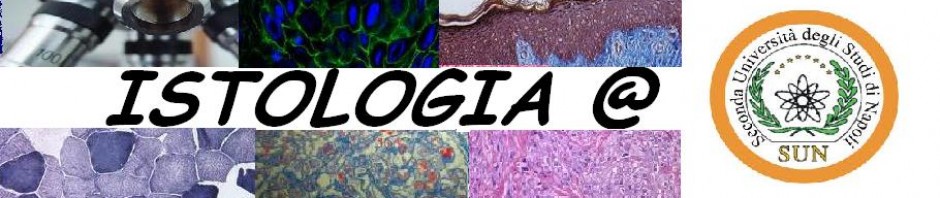




Bel post, mi piace! 🙂
Grazie mille, spero sia utile!
Scusami pietro paolo dove posso trovare altre esercitazioni di istologia?vorrei esercitarmi nel riconoscimento e visto che non mi pare siano state postate nuove esercitazioni mi andrebbero bene anche quelle degli anni passati…grazie mille e scusa il disturbo
Se scorri nella pagina trovi tutte le esercitazioni dell’anno scorso (tra l’altro con tutte le risposte nei commenti).
Ciao!
grazie…posso chiederti di chiarirmi qualche dubbio:
1-che cosa significa PAS positivo?sul libro non è molto chiaro
2-che cosa significa basofilia e acidofilia?pensavo di saperlo ma il libro sembra dire l’esatto opposto..io sapevo che il nucleo era basofilo cioè affine a coloranti basici avendo il DNA (acido) e il citoplasma acidofilo in quanto presenta proteine citoplasmatiche (basiche)
3-nel caso di ghiandola tubulare glomerulare la struttura a 8 o a maschera è data dal ripiegamento dell’adenomero tubulare oppure del dotto?
1-PAS positivo significa che é evidenziabile con il metodo PAS (Periodic Acid Schiff). Questo rivela peculiarmente i gruppi -OH liberi delle macromolecole (prevalentemente gli zuccheri legati alle proteine -> glicoproteine e proteoglicani). Risulta quindi un ottimo metodo per evidenziare le mucine.
2-la basofilia é l’affinitá per le sostanze basiche (es: acidi nucleici, eparina); l’acidofilia (o eosinofilia) é l’affinitá per le sostanze acide (es: zimogeni e proteine in genere). Non confonderti tra quando si parla dei coloranti e quando ci si riferisce alle molecole che hanno affinitá per i coloranti! Esempio: per colorare il nucleo (acido) ci vuole un colorante acidofilo (e quindi basico) -> il nucleo é basofilo, mentre il suo colorante é acidofilo.
3-da entrambe le strutture! Il dotto lo riconosci perché é costituito da 2 file di cellule cubiche, mentre l’adenomero è monostratificato ma rivestito esternamente da uno strato di cellule molto schiacciate ed eosinofile (le cellule mioepiteliali!).
Spero di aver chiarito i tuoi dubbi!
grazie mille x avermi risposto..posso chiederti un’altra cosa come faccio a discriminare nel riconoscimento l’adenoipofisi,la paratiroide e la ghiandola neuroendocrina(neuroipofisi)?c’è qualche dettaglio che a me sfugge che consentirebbe di disitinguerle?
-Adenoipofisi: ci sono piccoli agglomerati tondeggianti di cellule, separati da abbondanti vasi e fibre connettivali. Le cellule contigue presentano tipicamente affinitá tintoriali diverse (ricorda: acidofile, basofile, cromofobe). La colorazione migliore in questo caso è la PEO (PAS-Ematossilina-Orange), ma questo è un dato specialistico e te lo risparmio.
-Paratiroide: qui i cordoni cellulari (con cellule solo debolmente eosinofile o francamente cromofobe) si notano bene, e formano una serie di ripiegamenti che li fanno assomigliare quasi alle impronte digitali. Abbondante stroma ghiandolare è presente tra i cordoni.
-Neuroipofisi: questo è un caso particolare, infatti, non essendo una ghiandola di derivazione epiteliale mancano i cordoni (e ovviamente anche i follicoli!). Sono presenti cellule simil-gliali (i pituiciti, dotati di numerosi prolungamenti citoplasmatici, proprio come gli astrociti!) che non sono direttamente secernenti, ma fungono solo da sostegno agli assoni amielinici provenienti dall’ipotalamo. Gli ormoni (ossitocina e vasopressina/ADH) vengono infatti liberati DIRETTAMENTE dai terminali assonici nel vasi sanguigni. Questi terminali costituiscono delle strutture espanse, caratteristiche della neuroipofisi, note come “corpi di Herring”.
Per favore, da ora in poi inserisci le domande solo tra i commenti del post apposito, altrimenti gli altri avranno difficoltá a trovarle. Grazie.
si grazie e solo che non avevo capito dove poter fare le domande grazie ancora