Carissimi Studenti,
siamo giunti alla terza edizione dello spazio dedicato ai chiarimenti agli studenti, con domande e risposte facilmente consultabili da tutti.
Questo spazio non vuole e non può sostituirsi ai chiarimenti ottenibili in aula durante le lezioni, quando un docente può spiegare/rispiegare qualcosa in maniera immediata e con un’iconografia decisamente superiore. Questo spazio è riservato alle domande, alle difficoltà e ai dubbi sorti durante la fase di studio dell’Istologia e dell’Embriologia medica.
Vi preghiamo di:
-evitare domande sul programma di studio (già fornito con le diapositive delle lezioni);
-controllare che non ci sia già una risposta fornita al vostro interrogativo tra i commenti di questo post e degli analoghi degli anni scorsi, che vi consiglio vivamente di consultare prima di postare nuove domande:
https://istologiasun.wordpress.com/2013/04/11/chiariamoci-le-idee/ (edizione 2013);
https://istologiasun.wordpress.com/2014/04/05/q-a-2014/ (edizione 2014)
– porre solo domande per le quali non esista una risposta immediatamente accessibile sui libri di testo e sulle slides delle lezioni (ad esempio: “cosa sono i miofilamenti?”).
Inutile ricordarvi che tutte le domande sono soggette a controllo prima di essere pubblicate, quindi verranno accettate solo domande pertinenti provenienti da studenti iscritti alla scuola di Medicina della SUN (Napoli e Caserta).
Il tempo necessario per la risposta è variabile e dipende strettamente dagli impegni degli amministratori del blog.
Buono studio!
ppv
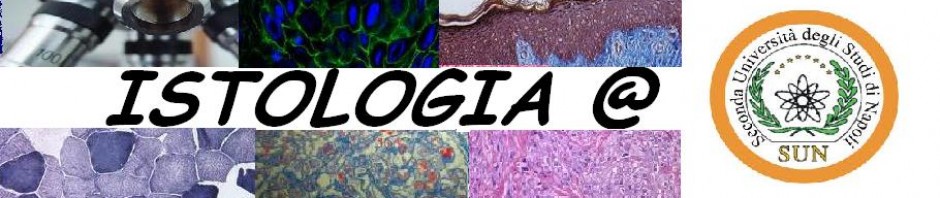
Salve professore, mi può riassumere il processo di formazione degli ormoni tiroidei T3 e T4? Grazie mille
Sono certo che troverai tantissimo a questo proposito sul testo e tra gli appunti delle lezioni. C’è qualche passaggio specifico che risulta poco chiaro?
PS: potresti identificarti? Non capisco se sei uno/a studente/ssa della nostra università. Grazie.
Salve professore , ho un dubbio: il pancreas è una ghiandola tubulo acinosa composta come d’altronde anche la parotide e la sottomandibolare, ma come è possibile identificare i tubuli se nella maggior parte dei preparati riesco a riconoscere solo acini .. Dipende dal modo in cui viene effettuato il taglio ? Grazie in anticipo
Durante la istogenesi delle ghiandole esocrine la porzione destinata a diventare adenomero cresce dapprima come tubulo e, successivamente, per un rigonfiamento della porzione distale dell’adenomero, si differenzia in acino o alveolo. È quindi normale che le ghiandole acinose composte (soprattutto quelle extraparietali come pancreas e parotide) presentino, se osservate estesamente, degli adenomeri tubulari. Questi ultimi non sono però sempre facilmente riconoscibili, motivo per cui sono spesso classificate come acinose composte invece che tubulo-acinose composte. In ogni caso, nessuna delle due dizioni è sbagliata.
Riguardo la sottomandibolare: i tubuli qui sono ben evidenti anche nell’adulto, soprattutto per gli adenomeri a secrezione mucosa.
Grazie mille , mi è molto più chiaro ora
Salve, ho le idee un po’ confuse per quanto riguarda la calcificazione della matrice ossea. Da quanto ho capito, questa è stimolata dalla presenza di una elevata concentrazione dello ione calcio che legandosi all’osteocalcina determina un aumento degli ioni fosfato grazie all’attivazione della fosfatasi alcalina. Questo genera un meccanismo a feedback positivo tra calcio e fosfato. Nel momento in cui si raggiunge la concentrazione soglia si ha l’esocitosi delle vescicole della matrice che grazie alla fosfatasi alcalina e a canali per il calcio e per il fosfato determinano l’entrata di questi ioni e la formazione di idrossiapatite. E’ corretto? Se così fosse, non riesco a capire cos’è che stimola l’aumento del calcio intracellullare e quale ruolo svolgano le altre glicoproteine. Grazie per l’attenzione.
La concentrazione di calcio NON aumenta in sede intracellulare (sarebbe letale per le cellule!), ma solo a livello delle matrix vesicles (prima) e della ECM (poi).
Tutta la mineralizzazione comincia con l’esocitosi delle vescicole della matrice, che si arricchiscono di calcio tramite apposite pompe ATPasiche e di fosfato tramite la degradazione dei pirofosfati e di altri esteri fosforici operata dalla fosfatasi alcalina. Quando la concentrazione di Ca e PO ha saturato l’ambiente della vescicola si formano dei cristalli aghiformi di idrossiapatite che distruggono lo strato lipidico della vescicola stessa. Il cristallo di idrossiapatite si localizza lí dove si era precedentemente fissata la vescicola grazie alla presenza dell’annessina V.
Riguardo le glicoproteine coinvolte nella matrice, esiste un commento già presente su questo blog sotto il post “Q & A – 2014”. Eccolo:
A riguardo dell’osteocalcina (OC): questa è una glicoproteina prodotta e secreta dagli osteoblasti che va incontro a processi di gamma-carbossilazione in alcuni sui residui di acido glutammico, così da legare facilmente il Calcio ionizzato (Ca2+). Il rilascio di questa proteina nella matrice extracellulare è un evento chiave dell’ossificazione, tanto che essa è considerata un vero e proprio marker molecolare del processo, essendo espressa in TUTTE le fasi dell’ossificazione (basta ricordare la sequenza in cui vengono espresse le glicoproteine nel corso della mineralizzazione: OC + OP -> OC + BSP -> ON + OC -> OC). Bisogna quindi ricordare che l’OC è una vera e propria regolatrice del processo, in quanto non solo lega il calcio alla matrice, ma ha anche una funzione di segnale locale dello stato di mineralizzazione della matrice (segnale che agisce sugli osteoblasti stessi), e addirittura (ci sono tante nuove ricerche a proposito) ha un ruolo di ormone, agendo su tessuti e organi a distanza, con un effetto positivo sul metabolismo. Qualcosa mi dice che fare anche una piccola revisione delle altre proteine del processo non è proprio inutile… Osteopontina (OP): è la prima sialoproteina ad essere prodotta durante la mineralizzazione (è presente già nell’osteoide). Ha il ruolo di favorire la iniziale nucleazione dei cristalli di calcio, favorendone anche l’interazione con il collagene di tipo I (o di tipo X, nel caso della matrice cartilaginea che ossifica a livello del disco metafisario). BSP: sta ad indicare la Bone SialoProtein, che guida la crescita in cristalli dell’idrossiapatite e la maturazione dell’osso. Osteonectina (ON): favorisce l’ulteriore nucleazione del calcio e la sua interazione con il collagene e gli altri elementi organici della ECM. E’ considerata una glicoproteina “tardiva”, in quanto viene espressa quando la calcificazione è già stata avviata.
Ciao
Buonasera,
Ripassando i complessi giunzionali mi sono imbattuta nelle “Giunzioni a Bottone”.
Cosa sono precisamente e dove si trovano principalmente?
Non ho trovato nulla di molto chiaro nel libro né nelle diapositive.
Grazie mille!
Forse è lo stesso delle giunzioni a Moneta? A lezione mi sembrava si aver capito che fosse diverso, ma non se ne è parlato molto, per cui sono in po’ confusa
La forma di “bottone” o “moneta” si riferisce alla piccola superficie di contatto tra le membrane delle cellule contigue unite da queste strutture, le maculae adhaerentes (o desmosomi)
Sono i desmosomi!
Salve,
Avrei alcune domande da fare:
1)Come fanno gli osteoclasti a liberare Ca se degradano solo la componente organica e non quella inorganica?
2)é giusto dire che durante la formazione dell intestino viene incluso l’endoderma embrionale ed extraembrionale?
3)Perche non è presente l’app di golgiin dendriti e gli altri organelli si?
4)Durante l’ossificazione endocondrale i condrociti vanno in apoptosi e vengono poi degradati dai condroclasti ma perchè vanno in apoptosi? Per l’invasione dei vasi o per la calcificazione?
5)Come interviene la vitamina C nella formazione dei legami a H nel tropocollagene?
6)La cartilagine ialina presenta pericondrio con tessuto conn. denso regolare mentre nel tessuto osseo il periostio è tessuto connettivo denso irregolare. E’ giusto?
1)I clasti degradano anche la matrice inorganica, grazie alla fosfatasi acida che aumenta la loro solubilizzazione;
2)non capisco la domanda
3)nei dendriti avviene regolare sintesi proteica, ma scarsa o assente produzione di vescicole: per questo le cisterne del Golgi sono scarse o assenti.
4)vanno in apoptosi perché perdono un supporto trofico (la matrice calcificata non permette la diffusione di metaboliti)
5)la vitamina C è un fattore riducente che funziona come coenzima per la lisil-ossidasi (l’HyLys è fondamentale per formare i cross-link tra diverse molecole di collagene)
6)si, esatto
Salve professore, se possibile vorrei chiarimenti su come distinguere facilmente la cartilagine Ialina da quella Elastica. Grazie in anticipo.
Nella cartilagine ialina matura (dell’adulto) l’aspetto della matrice extraterritoriale è solitamente chiaro (assume il colore più pallido della gamma cromatica in base al metodo utilizzato), mentre è generalmente presente un’intensa metacromasia della cartilagine territoriale. I gruppi isogeni sono ben distanziati tra loro.
In quella elastica è sempre riconoscibile una componente fibrillare (in genere si utilizza la colorazione con orceina, o la van Gieson) che si dispone esclusivamente nella matrice extraterritoriale. Le fibre possono essere molto sottili o raggrupparsi in fascetti, e conservano sempre un andamento ondulato, tipico delle fibre elastiche (più facile da osservare con le fibrille sottili). I gruppi isogeni talora sono più ravvicinati, anche se questa non è la caratteristica differenziale più importante.
Salve, avrei un dubbio riguardo alla formazione dell’ apparato urinario: confrontando due testi differenti in uno si afferma che tutte le strutture derivanti dal pronefro degenerano rapidamente, nell’ altro invece che dai dotti pronefrici originano i dotti di Wolff. Quale sarebbe la versione corretta?
Grazie in anticipo per la disponibilità
Il dotto di Wolff si forma da un’invaginazione tubuliforme della porzione laterale del mesoderma intermedio, percorrendolo per tutta la sua lunghezza. È generalmente accettato che tutto ciò che permanga come struttura organogenetica sia la sua porzione mesonefrica, mentre la porzione craniale (che prende contatto con i primitivi tubuli pronefrici) degeneri rapidamente.
Salve, vorrei chiedere chiarimenti riguardo alle cellule della glia radiale (istogenesi del sistema nervoso). Confrontando due testi, ho riscontrato che: per un autore, esse derivano dai glioblasti; per l’altro invece, esse derivano direttamente da cellule neuroepiteliali e hanno capacità di generare neuroblasti e i glioblasti (dopo aver cessato la produzione di neuroblasti). Quale delle due versioni è corretta?
Grazie per l’attenzione,
Antonio Carobene
Nello studio delle linee differenziative è frequentissimo imbattersi in queste piccole discordanze tra i testi (basti notare la fortissima discordanza riguardo le linee emopoietiche).
Anche in questo caso, come sempre, ci tengo a ricordare che è superfluo cercare una “verità” tra le due versioni: l’importante è ricordare che queste cellule derivino dalle cellule neuroepiteliali, capaci di formare sia neuroblasti che glioblasti. Che la glia radiale si formi direttamente a partire dalle cellule neuroepiteliali o abbia un progenitore intermedio glioblastico, ha davvero poca importanza.
Grazie per la risposta.
Salve,
durante lo studio del tessuto muscolare ho trovato informazioni contrastanti riguardo la presenza della miomesina e della proteina M. Da alcuni testi di evince che la miomesina serve ad ancorare la titina a livello della linea M e che sia, quindi, indispensabile nell’organizzazione dei miofilamenti spessi, da altri testi invece risulta che la miomesina è in realtà addirittura assente a livello di alcune fibre e che sia la proteina M ad avere le funzioni suddette. E’ possibile ottenere un chiarimento sulla funzione di queste due proteine e sulla loro presenza all’interno dei miofilamenti?
Grazie mille.
Spesso le domande su questo blog si concentrano su argomenti così specifici che possono essere definite “curiosità”, più che richieste di chiarimenti.
La miomesina è riconosciuta senz’ombra di dubbio per la sua funzione stabilizzante i sarcomeri, in quanto responsabile del legame tra miosina e titina a livello della linea M. La proteina M ha un ruolo ancora poco chiaro, probabilmente di tipo strutturale, sempre a livello della linea M.
Purtroppo non sono in grado di dare risposte esaustive per questi dubbi (ho anche cercato in letteratura), anche se dubito che siano proprio in primo piano nella ricerca sulla fisiologia/patologia dei muscoli striati.
Per adesso è meglio dedicare le nostre energie a qualcosa di più importante 🙂
Buono studio!
Salve professore, vorrei chiarimenti per quanto riguarda la selezione positiva e negativa dei timociti.. In cosa consiste? Grazie mille in anticipo
Questo argomento è abbastanza complesso, per cui consiglio di approfondirlo. Per essere brevi:
-Selezione positiva: vengono salvati i timociti che esprimono un TCR capace di legare (a bassa affinità) l’MHC I/II esposto dalle cellule epiteliali timiche. Vengono distrutti (mandati in apoptosi da stimoli locali) i timociti che hanno prodotto un TCR “difettoso”.
-Selezione negativa (solo per i timociti che hanno già superato la selezione positiva): vengono deleti (mandati in apoptosi e fagocitati) tutti i timociti che riconoscono antigeni SELF tramite il loro TCR.
Per farla breve, le due selezioni servono a:
-far sopravvivere solo i timociti che hanno prodotto un TCR funzionante (sel pos)
– tra questi, far sopravvivere solo quelli che con questo TCR funzionante non riconoscono antigeni self (sel neg), cioè circa il 2-5% del numero iniziale.
Buona sera, avrei bisogno di alcuni chiarimenti circa la formazione dell’arto ( va bene parlare di CEA, Zona di allungamento e ZPA?) e come incentrare il discorso sul chinociglio. grazie mille!
Puoi porre la domanda in modo più diretto? Non capisco dove sia il dubbio. C’è qualcosa in particolare che è poco chiaro?
Salve, volevo sapere se è completo parlare di formazione dell arto, parlando di CEA, ZPA e zona di allungamento. È sufficiente?
Già che ci sono: ho riscontrato alcune differenze sui testi circa la presenza o meno dei centrioli nel pirenoforo. Il nostro testo di riferimento dice che c è una coppia di centrioli che però serve per il COMT. Va bene dire così?
-Sì, quando si parla dello sviluppo degli arti è corretto parlare di questo. Magari correlato con la tempistica, con la sede in cui ciò avviene, con i movimenti morfogenetici…
-al discorso sui centrioli nei neuroni dedicai un intero post su questo blog l’anno scorso. Per farla breve: oggi abbiamo evidenze che in alcuni neuroni manchino i centrioli, ma non siamo in grado di estendere questa osservazione a TUTTI i neuroni. Meglio non generalizzare.
Grazie mille!! Andrò a cercare il post!!
Buona giornata
Egr. Prof. buonasera,
mi scusi se le ripropongo una domanda alla quale ha già risposto, ma continuo ad avere dei dubbi riguardo il processo di mineralizzazione del tessuto osseo.
E’ giusto affermare: “nel processo di ossificazione, sia esso intramembranoso o endocondrale, il primo tessuto depositato dagli osteoblasti è un tessuto immaturo non lamellare (SPONGIOSA PRIMARIA) e non mineralizzato (OSTEOIDE).
Per completarsi, il processo di mineralizzazione il tessuto osseo necessità di diverse fasi.
Si inizia con l’aumento extracellulare di ioni calcio a livello delle regioni che devono essere mineralizzate.
In seguito all’aumento, gli ioni si legano alla OC (glicoproteina sintetizzata e prodotto dagli osteoblasti che subisce una gamma-carbossilazione per legare gli ioni calcio) e questo legame comporta l’ attivazione della FOSFATASI ALCALINA che induce un aumento di ioni fosfato (sempre a livello extracellulare).
Per un meccanismo di feedback positivo, l’aumento degli ioni fosfato induce un ulteriore aumento degli ioni calcio che a sua volta comporta il rilascio da parte degli osteoblasti delle MATRIX VESCICLES.
Queste, grazie all’intervento della FOSFATASI ALCALINA che presentano all’ interno, liberano il fosfato dalle componenti organiche presenti a livello della matrice extracellulare il quale, a questo punto, può entrare nelle vescicole insieme agli ioni calcio (solo il calcio grazie alla ANNESSINA V).
All’interno delle vescicole la FOSFATASI ALCALINA esegue modifiche a livello degli ioni garantendo la formazione dei CRISTALLI DI IDROSSIAPATITE (fosfato di calcio).
Questi, una volta ipertrofizzatisi, perforano la membrana della vescicola e vanno ad occupare le pozioni della matrice extracellulare.
Il processo termina grazie alla disposizione dei CRISTALLI nella matrice su strutture organiche ( le CRYSTAL GHOSTS) che favoriscono la crescita degli stessi e la disposizione prima esternamente e poi internamente alle microfibrille collagene.
In attesa di una sua risposta, la ringrazio e saluto cordialmente.
*ERRATA CORRIGE
Egr. Prof. buonasera,
mi scusi se le ripropongo una domanda alla quale ha già risposto, ma continuo ad avere dei dubbi riguardo il processo di mineralizzazione del tessuto osseo.
E’ giusto affermare: “nel processo di ossificazione, sia esso intramembranoso o endocondrale, il primo tessuto depositato dagli osteoblasti è un tessuto immaturo non lamellare (SPONGIOSA PRIMARIA) e non mineralizzato (OSTEOIDE).
Per completarsi il processo di mineralizzazione, il tessuto osseo necessita di diverse fasi.
Si inizia con l’aumento extracellulare di ioni calcio a livello delle regioni che devono essere mineralizzate.
In seguito all’aumento, gli ioni si legano alla OC (glicoproteina sintetizzata e prodotto dagli osteoblasti che subisce una gamma-carbossilazione per legare gli ioni calcio) e questo legame comporta l’ attivazione della FOSFATASI ALCALINA che induce un aumento di ioni fosfato (sempre a livello extracellulare).
Per un meccanismo di feedback positivo, l’aumento degli ioni fosfato induce un ulteriore aumento degli ioni calcio che a sua volta comporta il rilascio da parte degli osteoblasti delle MATRIX VESCICLES.
Queste, grazie all’intervento della FOSFATASI ALCALINA che presentano all’ interno, liberano il fosfato dalle componenti organiche presenti a livello della matrice extracellulare il quale, a questo punto, può entrare nelle vescicole insieme agli ioni calcio (solo il calcio grazie alla ANNESSINA V).
All’interno delle vescicole la FOSFATASI ALCALINA esegue modifiche a livello degli ioni garantendo la formazione dei CRISTALLI DI IDROSSIAPATITE (fosfato di calcio).
Questi, una volta ipertrofizzatisi, perforano la membrana della vescicola e vanno ad occupare le pozioni della matrice extracellulare.
Il processo termina grazie alla disposizione dei CRISTALLI nella matrice su strutture organiche ( le CRYSTAL GHOSTS) che favoriscono la crescita degli stessi e la disposizione prima esternamente e poi internamente alle microfibrille collagene.”
In attesa di una sua risposta, la ringrazio e saluto cordialmente.
-Riguardo l’osteoide, è corretto.
– il Calcio non aumenta primariamente a livello extracellulare, ma si accumula nella matrix vesicles dove cristallizza insieme al fosfato liberato dalla fosfatasi alcalina (che è sintetizzata dagli osteoblasti in forma attiva).
-Le vescicole si localizzano in prossimità delle teste delle molecole di collagene grazie alla annessina V (proteina transmembrana delle vescicole stesse che funge anche da canale per il calcio). L’accumulo di calcio e fosfato all’interno delle vescicole supera il livello di solubilità e causa la precipitazione dei cristalli aghiformi di idrossiapatite, che “rompono” le vescicole.
-L’OC lega il calcio libero e i cristalli di HA, unendo meccanicamente le componenti inorganica e organica della ECM dell’osso.
Spero di aver chiarito i dubbi!
La ringrazio per la risposta, adesso è tutto più chiaro.
distinti saluti.
Egr. Prof. Buonasera,
Ho un dubbio.
E’ giusto affermare che : “nella fase di aggregazione piastrinica del processo di coagulazione i trombociti modificano la loro conformazione (da discoidale a sferica prima e appiattita poi, grazie alla polimerizzazione dei monomeri di actina e miosina citoplamatici) non solo dopo aver aderito alle strutture sub-endoteliali grazie all’interazione tra glicoproteine piastriniche e subendoteliali (in seguito all’ espressione da parte delle cellule endoteliali adiacenti la rima di lesione del fattore di von willebrand e della trombospondina tissutale), ma anche successivamente all’intervento di “ADP” (potente aggregante prodotto dalla piastrina stessa) e della trombina (forma attiva della Protrombina attivata dalla tromboplastina tissutale e/o piastrinica)”.
Consapevole del fatto che l’argomento in questione non si limita ad una trattazione così breve,
In attesa di una Sua risposta, La ringrazio e saluto cordialmente.
Qualche appunto:
-l’aggregazione piastrinica non fa parte del processo della coagulazione, ma è una fase dell’emostasi. La coagulazione si riferisce esclusivamente alla cascata enzimatica che porta alla formazione del reticolo di fibrina;
-il vWF non viene “espresso” dagli endoteliociti, ma è presente in maniera costitutiva sul versante basale dell’endotelio, che viene esposto solo in caso di danno all’endotelio stesso;
Tutto il resto è corretto. Mi limito ad un cenno della fisiologia dell’emostasi (che studierete meglio più in là):
-fase vasopiastrinica: formazione del tappo piastrinico. Responsabile dell’arresto dell’emorragia, coinvolge i vasi (vasocostrizione) e l’attivazione piastrinica, che vanno di pari passo e sono attivate dagli stessi mediatori;
-fase coagulativa: si avvia contestualmente a quella vaso-piastrinica, ma raggiunge un optimum dopo alcuni minuti. È responsabile della stabilizzazione del tappo piastrinico attraverso la formazione del reticolo di fibrina.
Buona serata.
Egr. Prof. buongiorno,
CREDO di aver ben appreso i primi meccanismi di sviluppo dell’apparato cardiovascolare, ma comunque gradirei averne conferma da parte Sua.
E’ giusto affermare che:
“L’apparato cardiovascolare è uno dei primi ad abbozzarsi intorno alla 3 settimana quando l’embrione non è più in grado di sostenere la propria struttura mediante semplici meccanismi di diffusione tra le lacune sanguigne (ottenute dall’erosione mediata da sinciziotrofoblasto con l’espressione di metalloproteasi e urochinasi) e i villi secondari (sinciziotrofoblasto, citotrofoblasto e mesoderma extraembrionale).
Le prime strutture si vengono a formare a livello del mesoderma extraembrionale splancnico (che riveste sacco vitellino) dal quale alcune cellule si distaccano per mutare in ANGIOBLASTI formanti le ISOLE ANGIOBLASTICHE nelle porzioni di sacco vitellino e peduncolo di connessione.
Le isole a loro volta si dividono in porzione centrale, dalla quale originano eritrociti primitivi, e porzione esterna, dalla quale originano le cellule endoteliali che andranno a formare le pareti dei vasi.
Questi processi vanno sotto il nom di “angiogenesi”, ovvero meccanismo che porta alla formazione dei primi vasi a livello extraembrionale (sacco vitellino e corion)
[con la comparsa dei vasi nel mesoderma extraembrionale il villo secondario diviene terziario].
Con la comparsa dei primi abbozzi vascolari a livello extraembrionale, anche a livello embrionale inizia la formazione dei vasi sanguigni e, in aggiunta, quella dell’abbozzo del cuore.
Per i vasi si iniziano a distaccare le prime cellule a partire dal mesoderma embrionale splancnico che procederanno con meccanismo simile a quello verificatosi nella porzione extraembrionale sino a determinare formazione di vasi embrionali che si andranno ad unire ai vasi extraembrionali mediante vasculogenesi.
Per quanto riguarda il cuore, invece, c’è da dire che è uno dei primi organi che si viene a formare (19 giorno come inizio del processo) a partire sempre dal mesoderma laterale splancnico. Difatti da questa struttura si distaccano alcune cellule che migrano verso la porzione anteriore della linea primitiva assumendo traiettoria cranio-laterale sino porsi in stretta vicinanza con l’endoderma sottostante e dare origine alle “regioni formanti il cuore” nella splancnopleura craniale.
Quando queste cellule raggiungono le pareti dell’intestino faringeo smettono di migrare e formano i CAMPI CARDIACI (primari e secondari).
Alcune cellule lasceranno suddetti campi, si differenzieranno prima in angioblasti e poi in angiociti per formare i due TUBI ENDOCARDICI PRIMITIVI” ( e da qui poi continuare con il processo di fusione dei tubi con formazione del tubo cardiaco definitivo etc. etc. etc…..)
La ringrazio anticipatamente per una Sua cortese risposta e mi scusi se non ho postato una domanda diretta.
Distinti saluti,
V.LABRIOLA
Si, hai scritto tutto correttamente. Molto bene!
Buongiorno gentilissimo Professore,
volevo porle una domanda di embriologia riguardo lo sviluppo degli abbozzi delle gonadi.
Gli abbozzi delle gonadi sono di origine mesodermica,derivano dal mesoderma laterale,precisamente da quella piccola parte dell’epitelio celomatico della splancnopleura che entra in contatto con mesonefro. Essi compaiono come due ispessimenti della superficie del mesonefro,chiamati creste genitali. Gli ispessimenti sono formati da cellule che provengono sia dall’epitelio celomatico (cortex) sia dal mesenchima del mesonefro sottostante (medulla).
Non mi è molto chiara la differenza tra cortex e medulla e la loro relativa origine.
Grazie mille,scusate il disturbo.
Cordiali saluti.
Scusate ancora,volevo anche una delucidazione riguardo la differenza tra accrescimento della cartilagine per apposizione e accrescimento interstiziale.
Grazie ancora.